
Da qualche settimana già ci penso su, da mesi so che devo farlo. Per il ventennale di Genova molto si sta muovendo, e anche per fronteggiare tutto quello che sta arrivando ho sentito la necessità di prepararmi. #genovanonèfinita dice un hashtag che si affaccia su Twitter. Ma cosa è stata? Il podcast Il salto scritto da @smenafra – Sara Menafra – con l’editing di @Majunteo – Matteo Miavaldi, disponibile su RaiPlayRadio e sul sito di Radio 3 dice bene: “se avete almeno 35 anni, e i primi 20 li avete passati in Italia, la morte di Carlo Giuliani e le giornate del G8 di Genoa probabilmente sono state un punto di rottura della vostra giovinezza”.
(A proposito di podcast consiglio quello di @RadioCaneMilano e quello curato da Annalisa Camilli per Internazionale, ancora in corso, un episodio a settimana a partire dal 16 giugno, saranno infine 8 episodi, dal titolo Limoni).
Il movimento dei movimenti
Alla fine del Ventesimo secolo i movimenti contro la globalizzazione capitalista alzavano la testa e si scoprivano forti anche attraverso la scelta di costituire dei controvertici in opposizione al “governo dei potenti”: il G8, ora G7 dopo la sospensione della Russia per via dei fatti di Crimea, che poi si è ritirata, tanto sta nel G20 (l’ultimo vertice si è tenuto a fine giugno in Cornovaglia), il WTO, la Banca mondiale. Proprio al volgere del secolo, a Seattle in occasione del vertice del WTO il movimento si impose di fronte all’opinione pubblica mondiale, impedendo l’inaugurazione dell’evento. Su Radio Onda Rossa tra gli speciali in vista del ventennale di Genova si possono ascoltare due puntate sulla “stagione dei controvertici“. Genova è stato il punto culminante di quel movimento, chi è andato a Genova sapeva l’importanza di esserci, col senno di poi, cercando capire i motivi della sconfitta, o quanto meno del riflusso del movimento, c’è chi ha detto che l’attenzione verso il grande “evento” è stato un errore strategico. (vedi negli anni successivi le riflessioni fatte dai Wu Ming nella allora newsletter Giap)
Per dare un’idea della tensione crescente nelle settimane e nei giorni precedenti si può seguire la Time machine realizzata da Indymedia, che sta rimettendo online tutto ciò che da loro venne pubblicato allora, giorno per giorno.
A vederlo in retrospettiva, vent’anni dopo, è difficile poter dare torto ai tantissimi che riempirono le piazze in quegli anni: le questioni poste dal movimento sono ancora all’ordine del giorno, la crisi del 2008 prima e la lunga crisi pandemica di cui non si vede la fine sembrano dire proprio “Avevate ragione voi” (https://yewtu.be/watch?v=dvu-3YzAkDw).
La “dichiarazione di guerra” delle tute bianche:
Alla Società Civile Globale;
al Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza – Italia
al Ministero della Difesa italiano – Capo di stato maggiore;
al Governo italiano – Presidenza del Consiglio – Presidente della Repubblica;
al Capo di Stato Maggiore FF.AA. Stati Uniti d’America – Ambasciata americana Roma;
Direzione C.I.A. – sede S.I.S.D.E. Roma;
DICHIARAZIONE DI GUERRA AI POTENTI DELL’INGIUSTIZIA E DELLA MISERIA
Apprendiamo da fonti giornalistiche italiane che i governi italiano e americano hanno deciso in una riunione svoltasi al Viminale, Roma, il 24 maggio 2001, di dichiarare formalmente guerra alle moltitudini di fratelli e sorelle che confluiranno a Genova durante il vertice del G8 previsto per luglio. La scelta di usare le vostre forze armate e i corpi speciali contro l’umanità, vi rende più vicini ai vostri alleati che nel sud del mondo quotidianamente uccidono, affamano, perseguitano chi non accetta lo sfruttamento del neoliberismo. In ogni parte di questo pianeta i vostri militari intervengono con i fucili contro le idee e i sogni di un mondo diverso, un mondo che contenga molti mondi. Il mondo che voi volete imporre anche nella vostra riunione di Genova, è un mondo unico, dove esista un pensiero unico, dove l’unica ideologia sia quella del denaro, dei profitti, del mercato delle merci e dei corpi. Il vostro mondo è un impero, voi gli imperatori, miliardi di esseri viventi semplici sudditi.
Dalle periferie di questo impero, dai molti mondi che resistono e crescono con il sogno di una esistenza migliore per tutti, oggi, noi, piccoli sudditi ribelli, vi dichiariamo formalmente guerra. È una scelta che voi avete provocato, perché noi preferiamo la pace, è una decisione che per noi significa sfidare la vostra arroganza e la vostra forza, ma siamo obbligati a farlo.
È un obbligo tentare di fermarvi perché finisca l’ingiustizia
È un obbligo dare voce ai fratelli e sorelle che in tutto il pianeta soffrono a causa vostra
È un obbligo non cedere alla paura dei vostri eserciti e alzare la testa
È un obbligo perché solo per obbligo noi dichiariamo le guerre. Ma se dobbiamo scegliere tra lo scontro con le vostre truppe d’occupazione e la rassegnazione, non abbiamo dubbi. Ci scontreremo.
Vi annunciamo formalmente che anche noi siamo scesi sul piede di guerra. Saremo a Genova e il nostro esercito di sognatori, di poveri e bambini, di indios del mondo, di donne e uomini, di gay, lesbiche, artisti e operai, di giovani e anziani, di bianchi, neri, gialli e rossi, disobbedirà alle vostre imposizioni. Noi siamo un esercito nato per sciogliersi, ma solo dopo avervi sconfitto. Oggi noi diciamo “Ya Basta!”.
Dalle periferie dell’Impero
Tute Bianche per l’umanità contro il neoliberismo
26 maggio 2001 – Genova, Italia, Pianeta Terra
Dalle moltitudini d’Europa in marcia contro l’Impero e verso Genova (19-21 luglio 2001)
Noi siamo nuovi, ma siamo quelli di sempre.
Siamo antichi per il futuro, esercito di disobbedienza le cui storie sono armi, da secoli in marcia su questo continente. Nei nostri stendardi è scritto “dignità”. In nome di essa combattiamo chi si vuole padrone di persone, campi, boschi e corsi d’acqua, governa con l’arbitrio, impone l’ordine dell’Impero, immiserisce le comunità.
Siamo i contadini della Jacquerie. I mercenari della Guerra dei Cent’anni razziavano i nostri villaggi, i nobili di Francia ci affamavano. Nell’anno del Signore 1358 ci sollevammo, demolimmo castelli, ci riprendemmo il nostro. Alcuni di noi furono catturati e decapitati. Sentimmo il sangue risalire le narici, ma eravamo in marcia ormai, e non ci siamo più fermati.
Siamo i ciompi di Firenze, popolo minuto di opifici e arti minori. Nell’anno del Signore 1378 un cardatore ci guidò alla rivolta. Prendemmo il Comune, riformammo arti e mestieri. I padroni fuggirono in campagna e di là ci affamarono cingendo d’assedio la città. Dopo due anni di stenti ci sconfissero, restaurarono l’oligarchia, ma il lento contagio dell’esempio non lo potevano fermare.
Siamo i contadini d’Inghilterra che presero le armi contro i nobili per porre fine a gabelle e imposizioni. Nell’anno del Signore 1381 ascoltammo la predicazione di John Ball: “Quando Adamo zappava ed Eva filava / chi era allora il padrone?”. Con roncole e forconi muovemmo dall’Essex e dal Kent, occupammo Londra, appiccammo fuochi, saccheggiammo il palazzo dell’Arcivescovo, aprimmo le porte delle prigioni. Per ordine di re Riccardo II° molti di noi salirono al patibolo, ma nulla sarebbe più stato come prima.
Siamo gli hussiti. Siamo i taboriti. Siamo gli artigiani e operai boemi, ribelli al papa, al re e all’imperatore dopo che il rogo consumò Ian Hus. Nell’anno del signore 1419 assaltammo il municipio di Praga, defenestrammo il borgomastro e i consiglieri comunali. Re Venceslao morì di crepacuore. I potenti d’Europa ci mossero guerra, chiamammo alle armi il popolo ceco. Respingemmo ogni invasione, contrattaccando entrammo in Austria, Ungheria, Brandeburgo, Sassonia, Franconia, Palatinato… Il cuore di un continente nelle nostre mani. Abolimmo il servaggio e le decime. Ci sconfissero trent’anni di guerre e crociate.
Siamo i trentaquattromila che risposero all’appello di Hans il pifferaio. Nell’anno del Signore 1476, la Madonna di Niklashausen si rivelò ad Hans e disse:
“Niente più re né principi. Niente più papato né clero. Niente più tasse né decime. I campi, le foreste e i corsi d’acqua saranno di tutti. Tutti saranno fratelli e nessuno possederà più del suo vicino.”
Arrivammo il giorno di S. Margherita, una candela in una mano e una picca nell’altra. La Santa Vergine ci avrebbe detto cosa fare. Ma i cavalieri del Vescovo catturarono Hans, poi ci attaccarono e sconfissero. Hans bruciò sul rogo. Non così le parole della Vergine.
Siamo quelli dello Scarpone, salariati e contadini d’Alsazia che, nell’anno del Signore 1493, cospirarono per giustiziare gli usurai e cancellare i debiti, espropriare le ricchezze dei monasteri, ridurre lo stipendio dei preti, abolire la confessione, sostituire al Tribunale Imperiale giudici di villaggio eletti dal popolo. Il giorno della Santa Pasqua attaccammo la fortezza di Schlettstadt, ma fummo sconfitti, e molti di noi impiccati o mutilati ed esposti al dileggio delle genti. Ma quanti di noi proseguirono la marcia portarono lo Scarpone in tutta la Germania. Dopo anni di repressione e riorganizzazione, nell’anno del Signore 1513 lo Scarpone insorse a Friburgo. La marcia non si fermava, né lo Scarpone ha più smesso di battere il suolo.
Siamo il Povero Konrad, contadini di Svevia che si ribellarono alle tasse su vino, carne e pane, nell’anno del Signore 1514. In cinquemila minacciammo di conquistare Schorndorf, nella valle di Rems. Il duca Ulderico promise di abolire le nuove tasse e ascoltare le lagnanze dei contadini, ma voleva solo prendere tempo. La rivolta si estese a tutta la Svevia. Mandammo delegati alla Dieta di Stoccarda, che accolse le nostre proposte, ordinando che Ulderico fosse affiancato da un consiglio di cavalieri, borghesi e contadini, e che i beni dei monasteri fossero espropriati e dati alla comunità. Ulderico convocò un’altra Dieta a Tubinga, si rivolse agli altri principi e radunò una grande armata. Gli ci volle del bello e del buono per espugnare la valle di Rems: assediò e affamò il Povero Konrad sul monte Koppel, depredò i villaggi, arrestò sedicimila contadini, sedici ebbero recisa la testa, gli altri li condannò a pagare forti ammende. Ma il Povero Konrad ancora si solleva.
Siamo i contadini d’Ungheria che, adunatisi per la crociata contro il Turco, decisero invece di muover guerra ai signori, nell’anno del Signore 1514. Sessantamila uomini in armi, guidati dal comandante Dozsa, portarono l’insurrezione in tutto il paese. L’esercito dei nobili ci accerchiò a Czanad, dov’era nata una repubblica di eguali. Ci presero dopo due mesi d’assedio. Dozsa fu arrostito su un trono rovente, i suoi luogotenenti costretti a mangiarne le carni per aver salva la vita. Migliaia di contadini furono impalati o impiccati. La strage e quell’empia eucarestia deviarono ma non fermarono la marcia.
Siamo l’esercito dei contadini e dei minatori di Thomas Muentzer. Nell’anno del Signore 1524, al grido di: “Tutte le cose sono comuni!” dichiarammo guerra all’ordine del mondo, i nostri Dodici Articoli fecero tremare i potenti d’Europa. Conquistammo le città, scaldammo i cuori delle genti. I lanzichenecchi ci sterminarono in Turingia, Muentzer fu straziato dal boia, ma chi poteva più negarlo? Ciò che apparteneva alla terra, alla terra sarebbe tornato.
Siamo i lavoranti e contadini senza podere che nell’anno del Signore 1649, a Walton-on-Thames, Surrey, occuparono la terra comune e presero a sarchiarla e seminarla. “Diggers”, ci chiamarono. “Zappatori”. Volevamo vivere insieme, mettere in comune i frutti della terra. Più volte i proprietari terrieri istigarono contro di noi folle inferocite. Villici e soldati ci assalirono e rovinarono il raccolto. Quando tagliammo la legna nel bosco del demanio, i signori ci denunciarono. Dicevano che avevamo violato le loro proprietà. Ci spostammo a Cobham Manor, costruimmo case e seminammo grano. La cavalleria ci aggredì, distrusse le case, calpestò il grano. Ricostruimmo, riseminammo. Altri come noi si erano riuniti in Kent e in Northamptonshire. Una folla in tumulto li allontanò. La legge ci scacciò, non esitammo a rimetterci in cammino.
Siamo i servi, i lavoranti, i minatori, gli evasi e i disertori che si unirono ai cosacchi di Pugaciov, per rovesciare gli autocrati di Russia e abolire il servaggio. Nell’anno del Signore 1774 ci impadronimmo di roccaforti, espropriammo ricchezze e dagli Urali ci dirigemmo verso Mosca. Pugaciov fu catturato, ma il seme avrebbe dato frutti.
Siamo l’esercito del generale Ludd. Scacciarono i nostri padri dalle terre su cui vivevano, noi fummo operai tessitori, poi arrivò l’arnese, il telaio meccanico… Nell’anno del Signore 1811, nelle campagne d’Inghilterra, per tre mesi colpimmo fabbriche, distruggemmo telai, ci prendemmo gioco di guardie e conestabili. Il governo ci mandò contro decine di migliaia di soldati e civili in armi. Una legge infame stabilì che le macchine contavano più delle persone, e chi le distruggeva andava impiccato. Lord Byron ammonì:
“Non c’è abbastanza sangue nel vostro codice penale, che se ne deve versare altro perché salga in cielo e testimoni contro di voi? Come applicherete questa legge? Chiuderete un intero paese nelle sue prigioni? Alzerete una forca in ogni campo e appenderete uomini come spaventacorvi? O semplicemente attuerete uno sterminio?… Sono questi i rimedi per una popolazione affamata e disperata?”.
Scatenammo la rivolta generale, ma eravamo provati, denutriti. Chi non penzolò col cappio al collo fu portato in Australia. Ma il generale Ludd cavalca ancora di notte, al limitare dei campi, e ancora raduna le armate.
Siamo le moltitudini operaie del Cambridgeshire, agli ordini del Capitano Swing, nell’anno del Signore 1830. Contro leggi tiranniche ci ammutinammo, incendiammo fienili, sfasciammo macchinari, minacciammo i padroni, attaccammo i posti di polizia, giustiziammo i delatori. Fummo avviati al patibolo, ma la chiamata del Capitano Swing serrava le file di un esercito più grande. La polvere sollevata dal suo incedere si posava sulle giubbe degli sbirri e sulle toghe dei giudici. Ci attendevano centocinquant’anni di assalto al cielo.
Siamo i tessitori di Slesia che si ribellarono nell’anno 1844, gli stampatori di cotonate che quello stesso anno infiammarono la Boemia, gli insorti proletari dell’anno di grazia 1848, gli spettri che tormentarono le notti dei papi e degli zar, dei padroni e dei loro lacchè. Siamo quelli di Parigi, anno di grazia 1871.
Abbiamo attraversato il secolo della follia e delle vendette, e proseguiamo la marcia.
Loro si dicono nuovi, si battezzano con sigle esoteriche: G8, FMI, WB, WTO, NAFTA, FTAA… Ma non ci ingannano, sono quelli di sempre: gli écorcheurs che razziarono i nostri villaggi, gli oligarchi che si ripresero Firenze, la corte dell’imperatore Sigismondo che attirò Ian Hus con l’inganno, la Dieta di Tubinga che obbedì a Ulderico e annullò le conquiste del Povero Konrad, i principi che mandarono i lanzichenecchi a Frankenhausen, gli empii che arrostirono Dozsa, i proprietari terrieri che tormentarono gli Zappatori, gli autocrati che vinsero Pugaciov, il governo contro cui tuonò Byron, il vecchio mondo che vanificò i nostri assalti e sfasciò ogni scala per il cielo.
Oggi hanno un nuovo impero, su tutto l’orbe impongono nuove servitù della gleba, si pretendono padroni della Terra e del Mare.
Contro di loro, ancora una volta, noi moltitudini ci solleviamo.
Genova.
Penisola italica.
19, 20 e 21 luglio
di un anno che non è più di alcun Signore.
Nei cortei erano previsti e si mossero spezzoni diversi, tutte le diverse anime del movimento erano rappresentate, non tutti sposavano gli stessi metodi di stare in piazza. E poi c’erano i black bloc, che le forze dell’ordine usarono come alibi per reprimere violentemente il movimento. Difficile dire che fu pianificato, altrettanto complicato dare la colpa solo ad impreparazione ed errori tattici. Non è “solo” morto un ragazzo, è stato un inferno e riguardando il materiale video, riascoltando quello audio, le testimonianze, le ricostruzioni, si può affermare che se non ci sono stati altri morti è stato un miracolo.
Su Carlo, a me sale la rabbia ogni anno, perché con troppa superficialità c’è sempre ancora qualcuno che dice che l’estintore, e il passamontagna, e insomma se l’è cercata. Diverse registrazioni, sentite nel podcast di Annalisa Camilli, sono di cittadini che chiamavano la polizia chiedendo di intervenire perché “sfasciano tutto” e invocavano le maniere forti – d’altra parte di fronte alla mattanza molti altri aprirono le porte e diedero acqua e sollievo ai manifestanti. Quelle maniere forti che invece hanno saputo usare solo con i “deboli”, perché lo sappiamo che i black bloc sono stati lasciati agire indisturbati, da Marassi a Piazza Paolo da Novi (ci sarebbe anche da discutere della strumentalità della divisione tra manifestanti buoni e cattivi, tra noi e loro). Non dovrebbe stupire, e vent’anni dopo in seguito allo “scandalo” del carcere di Santa Maria Capua Vetere – qui il video, che io non ho visto perché non so se reggo – (e Modena, e quelli che passano in sordina?) non si è sollevata quasi nessuna protesta, perché gli ultimi tali sono, e pochi li difendono. Ritornare a Carlo è difficile. Mi arrabbio in primo luogo con me stessa, che quando lo vidi la prima volta con quell’estintore, avevo 15 anni, cerco di giustificarmi, pensai “cazzo, no”. E troppo velocemente giudicai. È forse il senso di colpa per quei giudizi frettolosi che oggi mi impedisce di passare oltre, e mi costringe a prendere posizione, puntualizzare, litigare e incazzarmi spesso. Perché è ancor più ingiustificabile oggi, dopo vent’anni, dare giudizi sommari. Compito di noi tutti è tenere viva la memoria e continuare quella lotta. Consiglio sempre comunque il post su Giap di ormai nove anni fa.
Genova si può raccontare da diverse angolazioni. Genova è anche un pezzo importante di storia del “mediattivismo“. Per chi ha vent’anni ora sembra banale, ma la costruzione corale, dal basso, del racconto delle giornate di Genova era una novità assoluta in un’epoca in cui non esistevano smartphone e le connessioni dei computer (desktop) erano lentissime. Senza il lavoro importante e in presa diretta di tanti non si sarebbe potuto squarciare il velo dell’informazione “ufficiale” in maniera immediata. L’Independent Media Center (Indymedia) è una rete di mezzi di comunicazione di massa e di giornalisti messa in piedi proprio in occasione delle proteste contro il vertice del WTO a Seattle, che si allargò con la costruzione di diversi nodi tra cui quello italiano nato nel 2000 (che chiuse nel 2006). Oggi è stato rimesso online con l’operazione Indymedia Time Machine di cui parlavo più sopra e il sito che si vede è quello aggiornato fino alla chiusura. Indymedia si trovava nel Media center allestito dal Genova Social Forum insieme ad altre realtà mediatiche, tra cui Radio GAP – Global Audio Project che riuniva radio comunitarie e di base da diverse città italiane, e furono vittime anch’essi della violenta irruzione della polizia la sera del 21 luglio 2001. Dinamopress ha preparato un ottimo speciale sul mediattivismo.
Su Wikipedia alla voce “Fatti del G8 di Genova” si parla di “scontri tra forze dell’ordine e manifestanti”. Quantomeno è una forzatura, se non una menzogna vera e propria: il termine scontro presuppone un fronteggiamento tra due schieramenti, ma in realtà sappiamo che i cortei, peraltro autorizzati, vennero caricati a freddo, senza alcun ordine ufficiale né giustificazione. E questo portò a Piazza Alimonda. Poi ci furono la Diaz, “una rappresaglia scientifica alla figuraccia mondiale per le prese in giro dei black bloc. Un tentativo, maldestro, di rifarsi un’immagine e una verginità giocando sporco, picchiando a freddo, sbattendo a Bolzaneto ospiti indesiderati assolutamente innocenti” (dal libro Diaz di Vincenzo Canterini, comandante della Mobile di Roma e tra i responsabili dell’irruzione) e Bolzaneto, con le torture non giudicate tali perché il nostro paese non prevedeva tale reato nell’ordinamento. Il reato di devastazione e saccheggio, dal codice fascista, invece lo prevedeva, e di quel reato sono stati accusati e condannati alcuni manifestanti, e le loro vicende giudiziarie non sono ancora concluse, mentre tra le forze dell’ordine ci sono state promozioni e tanti nulla di fatto nelle indagini per l’impossibilità di riconoscere i singoli responsabili.
Per il ventennale, dicevo, molto si sta muovendo. Scontata l’attenzione del mainstream, cui non bisogna lasciare il racconto:
Ma sono i protagonisti di allora, che nonostante la ferita ancora aperta, o forse anche per quello, che stanno contribuendo a mantenere viva la memoria, che non sia solo testimonianza ma anche riscatto. Qui il blog dedicato, con la speranza che il movimento torni a farsi sentire forte.

 Il libro di Roberto Ferrucci rientra nel mio piano di letture della lunga estate del ventennale, che per una serie di motivi si è protratto fino all’autunno. Fu pubblicato per la prima volta nel 2007 perché l’autore ci mise sei anni per liberarsi “di tutte le scorie intime e dolorose che i giorni di Genova avevano lasciato (…) poi per trovare la chiave narrativa che tenesse in piedi la storia” così nelle righe a chiusura della riedizione di quest’anno per people. Dice Tabucchi nella prefazione al libro che non è né una testimonianza né un romanzo: “è un testo letterario nel senso più potente, e secondo il compito più profondo che possa assumere la letteratura”. Se fosse semplicemente un romanzo sarebbe più semplice, ma sappiamo che purtroppo non si tratta di una storia di fantasia. La scrittura rende bene l’eccezionalità di quei giorni, il paradossale senso di irrealtà, rispetto a quello che sappiamo è accaduto e non immaginato, in cui ci si trovava immersi camminando per le strade di Genova:
Il libro di Roberto Ferrucci rientra nel mio piano di letture della lunga estate del ventennale, che per una serie di motivi si è protratto fino all’autunno. Fu pubblicato per la prima volta nel 2007 perché l’autore ci mise sei anni per liberarsi “di tutte le scorie intime e dolorose che i giorni di Genova avevano lasciato (…) poi per trovare la chiave narrativa che tenesse in piedi la storia” così nelle righe a chiusura della riedizione di quest’anno per people. Dice Tabucchi nella prefazione al libro che non è né una testimonianza né un romanzo: “è un testo letterario nel senso più potente, e secondo il compito più profondo che possa assumere la letteratura”. Se fosse semplicemente un romanzo sarebbe più semplice, ma sappiamo che purtroppo non si tratta di una storia di fantasia. La scrittura rende bene l’eccezionalità di quei giorni, il paradossale senso di irrealtà, rispetto a quello che sappiamo è accaduto e non immaginato, in cui ci si trovava immersi camminando per le strade di Genova:

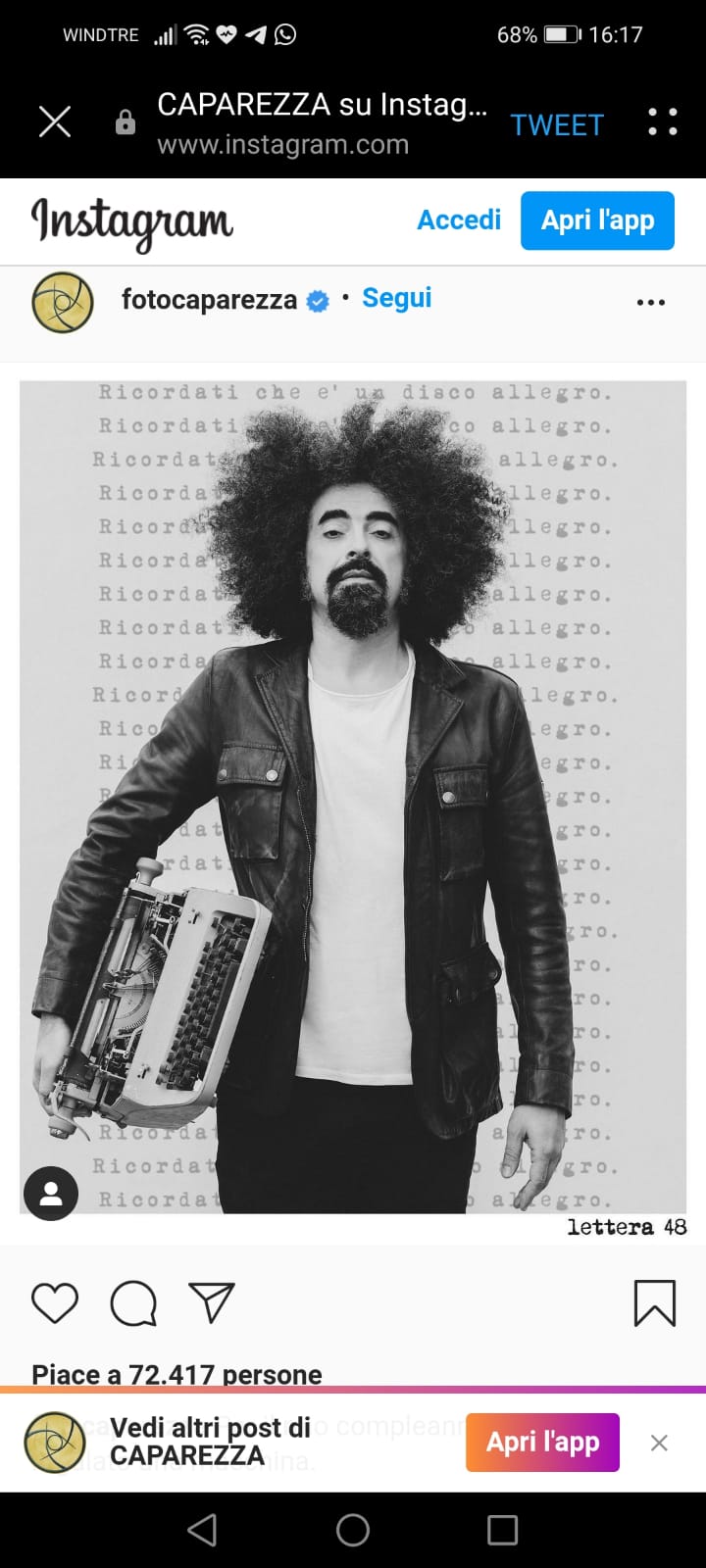
 Mauro Biani e Carlo Gubitosa, a cui devo dire grazie perché hanno messo in fila la serie di ragioni che sappiamo di avere, a volte solo intuitivamente o senza ragionarci abbastanza su, con una disamina puntuale, e sapendole mettere in prospettiva con le lotte sociali di oggi. Abbiamo ragione dunque, una ragione che non ci dà conforto, né tregua: perché sarebbe stato meglio per tutti avere avuto torto, oppure essere ascoltati vent’anni fa. Abbiamo, tutti, “perso” vent’anni – al netto della disillusione e del riflusso anche in parte fisiologico sappiamo che non è del tutto così, molti di noi hanno continuato, in mille forme diverse, le battaglie di allora – e avremmo potuto affrontare anche l’emergenza Covid in maniera sicuramente più efficace:
Mauro Biani e Carlo Gubitosa, a cui devo dire grazie perché hanno messo in fila la serie di ragioni che sappiamo di avere, a volte solo intuitivamente o senza ragionarci abbastanza su, con una disamina puntuale, e sapendole mettere in prospettiva con le lotte sociali di oggi. Abbiamo ragione dunque, una ragione che non ci dà conforto, né tregua: perché sarebbe stato meglio per tutti avere avuto torto, oppure essere ascoltati vent’anni fa. Abbiamo, tutti, “perso” vent’anni – al netto della disillusione e del riflusso anche in parte fisiologico sappiamo che non è del tutto così, molti di noi hanno continuato, in mille forme diverse, le battaglie di allora – e avremmo potuto affrontare anche l’emergenza Covid in maniera sicuramente più efficace:
 Nota a margine ma non fuori tema: Le cronache sono incartate nei dibattiti intorno all’obbligatorietà vaccinale, più surrettizia tramite il green pass che diretta, mentre il conflitto sociale, che aumenta e aumenterà, è rimosso dal discorso pubblico, ma torna prepotentemente per chi lo vuole vedere: le conseguenze dello sblocco dei licenziamenti passano dalla GKN con il loro bellissimo Insorgiamo (
Nota a margine ma non fuori tema: Le cronache sono incartate nei dibattiti intorno all’obbligatorietà vaccinale, più surrettizia tramite il green pass che diretta, mentre il conflitto sociale, che aumenta e aumenterà, è rimosso dal discorso pubblico, ma torna prepotentemente per chi lo vuole vedere: le conseguenze dello sblocco dei licenziamenti passano dalla GKN con il loro bellissimo Insorgiamo (


 Da aspirante disagiata, tenevo da un po’ in coda di lettura l’esordio saggistico di Raffaele Alberto Ventura, sul quale avevo visto molti rimandi e citazioni. Tocca leggerlo, mi dissi e finalmente l’ho fatto. Come mi ha detto Pietro ha molti spunti interessanti. Da sociologa mancata (a proposito di disagio) apprezzo molto i continui richiami teorici, sin dal titolo che evidentemente cita il classico di Veblen, così come gli innumerevoli rimandi letterari. L’autore ci parla invece del rischio concreto, nel senso che è già realtà in non pochi casi, del declassamento del ceto medio occidentale.
Da aspirante disagiata, tenevo da un po’ in coda di lettura l’esordio saggistico di Raffaele Alberto Ventura, sul quale avevo visto molti rimandi e citazioni. Tocca leggerlo, mi dissi e finalmente l’ho fatto. Come mi ha detto Pietro ha molti spunti interessanti. Da sociologa mancata (a proposito di disagio) apprezzo molto i continui richiami teorici, sin dal titolo che evidentemente cita il classico di Veblen, così come gli innumerevoli rimandi letterari. L’autore ci parla invece del rischio concreto, nel senso che è già realtà in non pochi casi, del declassamento del ceto medio occidentale.
 Sinceramente non ricordavo più la felice intuizione che mi fece incontrare il primo romanzo di Giovanni Arpino, ma fidandomi di una vecchia versione di me e cercando di snellire una coda di lettura che è diventata a tratti imbarazzante, l’ho preso in mano e devo dire di aver fatto proprio bene. Sei stato felice, Giovanni è un esordio brillante, e leggere che è stato scritto a 23 anni in venti giorni suscita ammirazione oltre che ‘sana’ invidia, di quella che ti sprona a far meglio, non a denigrare l’altro – semmai questa forma del sentimento esiste. La storia è un passaggio, un salto verso l’età adulta e si legge piacevolmente. Le descrizioni sono vivide, il protagonista è una figura a tutto tondo, di certo non un eroe, ma una persona con le sue idiosincrasie, coi suoi vizi e le sue crudeltà. Per citare Lagioia,
Sinceramente non ricordavo più la felice intuizione che mi fece incontrare il primo romanzo di Giovanni Arpino, ma fidandomi di una vecchia versione di me e cercando di snellire una coda di lettura che è diventata a tratti imbarazzante, l’ho preso in mano e devo dire di aver fatto proprio bene. Sei stato felice, Giovanni è un esordio brillante, e leggere che è stato scritto a 23 anni in venti giorni suscita ammirazione oltre che ‘sana’ invidia, di quella che ti sprona a far meglio, non a denigrare l’altro – semmai questa forma del sentimento esiste. La storia è un passaggio, un salto verso l’età adulta e si legge piacevolmente. Le descrizioni sono vivide, il protagonista è una figura a tutto tondo, di certo non un eroe, ma una persona con le sue idiosincrasie, coi suoi vizi e le sue crudeltà. Per citare Lagioia, 
